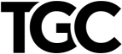Ogni giorno riceviamo input dalla cultura nella quale viviamo. Come porci di fronte a questi input, visto che ogni credente è chiamato a confrontarsi con la cultura e il contesto che lo circonda?
Feste patronali, musica non cristiana, Halloween, giochi di carte, battesimi e comunioni cattolici, cartoni animati, film che parlano di magia, feste in discoteca … potrei fare una lunga lista di aspetti culturali sui quali, negli ambienti evangelici, si è discusso negli anni.
La tentazione è di cedere ad uno dei due estremi: accettare completamente la cultura attorno a noi, o rigettarla in toto.
La tentazione è di cedere ad uno dei due estremi: accettare completamente la cultura attorno a noi, o rigettarla in toto. Temo che, in entrambi i casi, non riusciremo ad essere sale e luce nel mondo, senza essere del mondo. Voglio suggerire, con questa serie di quattro articoli, che la risposta a questi quesiti pressanti è da cercarsi in un’analisi culturale teologica. Si tratta di un esercizio che si può fare con qualsiasi “testo” culturale, dove, con testo, si intende una qualsiasi tendenza o artefatto culturale: un film, un evento, una tecnologia, un movimento, un’innovazione o una tradizione.
Voglio presentare un semplice modello che spero possa aiutarci a fare delle riflessioni culturali vangelocentriche. Il modello è preso dal libro Plugged In di Dan Strange.1
Il Signore ci ha creato con doni e sensibilità diverse, e una differenza di opinione su un’interpretazione della cultura attorno a noi non dovrebbe minare l’amore e il rispetto che abbiamo, in Cristo Gesù, gli uni per gli altri.
Provando ad applicare questo modello i “risultati” potrebbero essere, in alcuni casi, diversi da persona a persona. È normale ed è giusto così: il Signore ci ha creato con doni e sensibilità diverse, e una differenza di opinione su un’interpretazione della cultura attorno a noi non dovrebbe minare l’amore e il rispetto che abbiamo, in Cristo Gesù, gli uni per gli altri.
Il modello presentato da Strange è suddiviso in quattro fasi: Entrare; Esplorare; Esporre; Evangelizare. In questa serie di articoli, oltre a presentare il modello, lo applicherò praticamente ad un fenomeno culturale molto italiano: l’aperitivo. In questo modo sarà più facile capire di cosa stiamo parlando.
Entrare: immergersi nel mondo e ascoltare la storia
Questa prima fase consiste nell’ascoltare e comprendere il testo, fermarsi per osservarlo, studiarlo e capirlo. Per capire meglio il testo ci si può porre tre domande, che in questo caso ci facciamo per capire cos’è esattamente l’aperitivo.
Che cosa dice?
Attraverso la prima domanda cerchiamo di capire cosa caratterizza il testo che stiamo studiando, qual è il contenuto del testo, come si presenta, da cosa è riconoscibile, cosa dicono gli altri a riguardo. L’aperitivo, per esempio, è un momento specifico della routine quotidiana, la fine delle attività legate al dovere e l’inizio dell’importantissima parte ricreativa e sociale della vita.
Si presenta come amici che si riuniscono in un bar in una piazza d’Italia alla luce del tramonto. Il suono è quello dei drink versati, mescolato alle risate, alle chiacchiere e alla musica di sottofondo. Al tatto è composto da mani che si stringono, abbracci, baci; piatti, bicchieri, cannucce e posate, sedie e tavoli. Ha il sapore di uno Spritz, di un cocktail analcolico fruttato, di un buon vino o di una birra fresca e di diversi tipi di cibo: pizza, olive, cous-cous, pasta, formaggi, affettati, bruschette. Il profumo è quello dei cibi crudi, fritti o cucinati, unito agli odori e ai profumi di un gruppo eterogeneo di persone.
Ma l’aperitivo per gli italiani è più di un buon drink con qualche finger food. Una scrittrice di gastronomia descrive l’aperitivo come il “momento beato tra la fine del lavoro e il passaggio alla convivialità, il momento iniziale di felicità”2, e la chef italiana Varese aggiunge che l’aperitivo è “condivisione, è un’occasione di scambio, è il benvenuto della sera. È un inizio, è amicizia”.3
Chi l’ha scritto?
Attraverso questa domanda vogliamo capire chi c’è dietro il testo: da dove proviene, chi lo ha creato, inventato, promosso. Aperitivo, per esempio, deriva dal latino aperitivus che significa aprire, in riferimento alla fame che viene stimolata da esso. La diffusione dell’aperitivo moderno è legata a bevande specifiche e inizia nel 1786 a Torino, dove Antonio Carpano inventa il famoso Vermut. Nel XIX secolo, a Milano, Ausano Ramazzotti e Gaspare Campari inventarono due bevande altrettanto famose. L’abitudine di mangiare qualcosa insieme a queste bevande nacque perché per le donne era inopportuno assumere alcolici a stomaco vuoto. Questa tendenza divenne sempre più popolare, fino a diffondersi tra diverse regioni, generazioni e classi sociali durante gli anni ’70 e ’80. Ancora una volta, l’aperitivo non è solo cibo: “Per me è nato con il desiderio e la possibilità di staccare il tempo di lavoro dal tempo libero. L’aperitivo è una piccola vacanza che ci prendiamo ogni giorno”.4
Il 26 maggio 2022, durante la Giornata Mondiale dell’Aperitivo, chef di qualità, ambasciatori e istituzioni italiane (tra cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) hanno firmato il “Manifesto dell’Aperitivo”, composto da 10 punti per “riaffermare l’importanza del rito, simbolo dell’italianità.”5
Chi lo legge?
Rispondendo a questa domanda capiamo chi fa uso di un determinato testo: se è un prodotto diffuso o di nicchia; chi, se e come sta influenzando le persone. Il testo in questione è molto diffuso, visto che nel nostro Paese vengono serviti oltre 850 milioni di aperitivi l’anno.6 Quasi tutti, in Italia, prendono parte a questo momento. Ma osservando più attentamente questo testo possiamo notare che è in voga soprattutto tra chi vuole far parte di una comunità, chi vuole stare con amici, chi vuole far parte di un rito, chi vuole evadere dai problemi e dallo stress della vita lavorativa e ritrovarsi in un mondo di gioia, di festa, di nuove possibilità. Il foodwriter Barberini dice: “Per questo amo l’aperitivo: l’inizio di una serata, il preludio della convivialità, il momento iniziale di felicità.”7
Attraverso la prima fase siamo entrati nel mondo dell’aperitivo e abbiamo potuto notare che sono almeno tre gli elementi che lo caratterizzano e lo rendono così popolare: ritualità, comunità ed escapismo. Nei prossimi articoli li approfondiremo per capire in che modo il Vangelo può adempiere in maniera sovversiva la cultura dell’aperitivo.
Nel frattempo, perché non provi tu stesso ad entrare in un testo culturale che ti preoccupa, interessa, o attrae? Entra, rispondendo alle suddette domande, per scoprire cosa lo rende unico e popolare.
Primo di 4 articoli
DISCLAIMER: Questo contenuto esprime le posizioni e sensibilità dell’autore.
NOTA: Questo articolo è protetto da copyright. Ti preghiamo di guardare la pagina Autorizzazioni per eventuali utilizzi