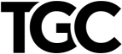Nota della redazione: Questo è un adattamento del capitolo 4, “Evangelical Self-Identity and the Doctrine of Biblical Inerrancy”, del libro Understanding the Times: New Testament Studies in the 21st Century: Essays in Honor of D. A. Carson on the Occasion of His 65th Birthday (Crossway, 2011). Qui la versione in PDF.
Carl F. H. Henry: Fondamentalista?
In un tardo pomeriggio dei primi anni Novanta, il dottor Carl F. H. Henry si dirigeva verso il suo prossimo appuntamento nella sede della Trinity Evangelical Divinity School di Deerfield, nell’Illinois. Sembrava molto concentrato. Io stavo andando verso la mia auto e lo raggiunsi sul marciapiede. Conoscevo il dottor Henry fin dai tempi della mia infanzia. Lui e mio padre erano stati colleghi al Fuller Theological Seminary negli anni Cinquanta.
Henry aveva sentito i miei passi, si era girato e mi aveva salutato calorosamente, ma non sembrava vivace come al solito. Avvertendo qualcosa di strano, gli chiesi quale fosse il problema. Mi rispose che di recente aveva avuto una conversazione spiacevole con un collega evangelico fuori dal campus. Questa persona aveva accusato il dottor Henry di essere un “fondamentalista”. Henry ha espresso la sua perplessità per l’accusa, ed era visibilmente turbato e rattristato dal modo in cui si era svolta la conversazione.
Così su due piedi l’accusa del critico non aveva alcun senso per me. Dopotutto Carl Henry era uno dei principali artefici della rinascita evangelica del secondo dopoguerra. Aveva scritto lo storico libro The Uneasy Conscience of American Fundamentalism. Aveva sfidato il movimento fondamentalista a riflettere sulle “implicazioni sociali che il loro messaggio avrebbe avuto sul mondo non cristiano”*.
Aveva scritto: “Oggi il fondamentalismo protestante, pur essendo erede del vangelo soprannaturalista delle menti bibliche e della Riforma, è estraneo, nel suo spirito predominante, al vigoroso interesse sociale dei suoi antenati ideologici”*. Pur criticando alcuni aspetti del fondamentalismo americano, Henry sosteneva molti degli stessi “fondamenti” dottrinali dei fondamentalisti.
Tuttavia negli anni Quaranta e Cinquanta cominciò chiaramente a identificarsi più come evangelico che come fondamentalista. Dal 1947 al 1956 insegnò al Fuller Theological Seminary, una scuola evangelica. Dal 1956 al 1968 è stato redattore della rivista evangelica di punta Christianity Today. Ha inoltre riflettuto seriamente riguardo ai tratti caratteristici dell’identità evangelica. Nel 1976 ha pubblicato il libro Evangelicals in Search of Identity. Di conseguenza, quando uno studioso evangelico definì il dottor Henry un fondamentalista, egli ebbe le sue buone ragioni per essere sorpreso. Sentiva inoltre di essere stato evidentemente etichettato ingiustamente.
Al momento del nostro breve incontro sul marciapiede, non chiesi a Henry quale fosse la giustificazione fornita dal suo interlocutore per formulare l’accusa. Ho in seguito cercato di capire perché il rispettato critico avesse descritto il dottor Henry, un uomo con impeccabili “credenziali evangeliche”, come fondamentalista. Aveva semplicemente pronunciato l’accusa per rabbia? Non potevo saperlo. Ma, come ammiratore del critico, volevo pensare il meglio. Conclusi che questa persona aveva apparentemente creduto in buona fede che l’impegno di Henry nella dottrina dell’inerranza biblica lo rendesse un fondamentalista.
La dottrina storica dell’inerranza biblica
All’inizio degli anni Novanta era emersa una potente storiografia che dipingeva la dottrina dell’inerranza biblica come “fondamentalista”, e non come una dottrina “evangelica”. Tenendo presente questa storiografia, il critico potrebbe essersi sentito pienamente giustificato nell’etichettare il dottor Henry come un fondamentalista. Per il critico, Henry avrebbe semplicemente sbagliato ad identificarsi come evangelico.
Ovviamente la mia ricostruzione di ciò che può aver motivato il critico nel porre una tale etichetta è puramente speculativa. Ciò che non è speculativo, invece, è il fatto che il modo in cui gli storici raccontano le traiettorie storiche di varie dottrine spesso influenza la nostra visione di queste ultime. Se, per esempio, gli storici ritraggono una dottrina come teologicamente innovativa, un allontanamento da ciò che le Chiese cristiane hanno costantemente insegnato, possiamo sospettare che questa dottrina si sia allontanata dalla fede “che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre”. E gli evangelici hanno un interesse particolare nello studiare la storia di una dottrina.
Identificare e aderire alle dottrine e alle confessioni centrali della Chiesa è una cosa molto importante per noi, anche se riteniamo che la Scrittura sia la nostra autorità ultima e definitiva. Una simile impresa può fornirci una migliore comprensione della nostra propria identità teologica evangelica. Le nostre convinzioni sull’autorità scritturale, ad esempio, si collocano all’interno di insegnamenti centrali identificabili nella Chiesa cristiana storica? Se così non fosse, potremmo essere diventati degli innovatori dottrinali per quanto riguarda la nostra visione delle Scritture, nonostante le nostre intenzioni di sostenere l’insegnamento cristiano ortodosso.
Osservare e rispettare le dottrine e le confessioni centrali della Chiesa può anche aiutarci ad evitare errori teologici. In The Mark of Jesus di Timothy George, rettore della Beeson Divinity School, viene descritto molto bene il valore delle dichiarazioni di fede:
In che modo tali dichiarazioni di fede servono la causa dell’unità evangelica? Forse è utile paragonarle ai guardrail che aiutano un automobilista, soprattutto in caso di maltempo, a percorrere una strada stretta e insidiosa, o i tornanti di una pericolosa stradina di montagna. Questi guardrail stabiliscono dei limiti che ci proteggono dal pericolo di finir giù da uno strapiombo. Solo un pazzo con tendenze suicide vorrebbe attraversare senza guardrail una catena montuosa come le Alpi svizzere. Sarebbe altrettanto folle, naturalmente, utilizzare il guardrail come se fosse la strada! Anche perché, se con la macchina ci siamo finiti sopra, allora è pur certo che la catastrofe sia imminente.
Per il cristiano la strada è una sola. Gesù ha detto: “Io sono la via, la verità e la vita” (Giovanni 14:6). O, per dirla con Agostino, Cristo è “al tempo stesso la nostra patria e la via che conduce a quella patria”*. Questa analogia non è perfetta, naturalmente. Tuttavia potremmo spingerci un po’ più in là e affermare che la Bibbia è la nostra cartina stradale, una risorsa indispensabile e divinamente conferita che ci aiuta a trovare la strada e a mantenerci su di essa, mentre lo Spirito Santo ci aiuta a vedere sia la strada che i guardrail [dichiarazioni di fede], e a mantenere entrambi nella giusta prospettiva.*
In questo saggio ribadirò la tesi secondo cui l’inerranza biblica sia stata una dottrina ecclesiastica o un insegnamento centrale agostiniano delle chiese cristiane occidentali, comprese le chiese protestanti evangeliche. Ne consegue che gli evangelici che affermano la dottrina dell’inerranza biblica non siano affatto degli innovatori dottrinali. Con l’espressione inerranza biblica intendo la dottrina secondo cui la Bibbia sia infallibile tanto per quanto riguarda la fede e la pratica, quanto per ciò che concerne le questioni storiche e scientifiche. Con l’espressione dottrina ecclesiastica mi riferisco a una convinzione diffusa e condivisa dalle chiese cristiane che hanno avuto un’esistenza storica in Occidente.
La nuova visione dell’inerranza biblica
Come già osservato, non tutti i teologi e gli storici della Chiesa sono d’accordo sul fatto che l’inerranza biblica sia stata di fatto un insegnamento centrale delle Chiese occidentali. E anzi negli ultimi quarant’anni è emersa un’influente storiografia a sostegno del fatto che l’inerranza biblica sia in realtà un’innovazione dottrinale che trova le sue origini nel fondamentalismo americano, a sua volta dipinto come un movimento dottrinalmente innovativo e quindi sospetto.
Fino agli anni Settanta la maggior parte degli evangelici riteneva che l’inerranza biblica fosse una convinzione fondamentale non negoziabile. In The Evangelicals: What They Believe, Who They Are, Where They Are Changing, libro del 1975 curato da David Wells e da me, Martin Marty dell’Università di Chicago affermava che evangelici e fondamentalisti condividessero la dottrina dell’inerranza biblica: “Sia gli evangelici che i fondamentalisti insistono sul fatto che l’‘inerranza delle Scritture’ sia il più fondamentale tra tutti i loro fondamenti”*.
Tuttavia, sotto l’influenza della nuova storiografia, un buon numero di storici e teologi ha successivamente rifiutato di accettare la validità della valutazione del professor Marty. Ciò che rivendicavano, infatti, era che fossero i soli fondamentalisti a sostenere l’inerranza biblica, non gli evangelici. Negli anni ’80 Marty stesso identificava la dottrina dell’inerranza biblica più come una dottrina fondamentalista che come la dottrina “più fondamentale” degli evangelici.
Questa nuova storiografia ha suggerito che l’inerranza biblica non fosse né una dottrina evangelica né un insegnamento centrale delle chiese cristiane occidentali. Si sarebbe piuttosto trattato di una convinzione prototipica fondamentalista che avrebbe avuto origine alla fine del XIX secolo. L’espressione fondamentalista vera e propria si è diffusa solo a partire dal 1920. In quell’anno Curtis Lee Laws (1868-1946) introdusse l’espressione in un editoriale del Watchman Examiner: “Suggeriamo che coloro che si aggrappano ancora ai grandi fondamenti, e che per tali fondamenti intendano portare avanti un’accesa disputa, siano chiamati ‘Fondamentalisti’”*.
La nuova storiografia secondo cui l’inerranza biblica sia una dottrina fondamentalista ha plasmato il pensiero di alcuni illustri teologi e storici della Chiesa protestante e cattolica.
Nel 1970 lo storico Ernest Sandeen ha contribuito ad avviare questa influente storiografia in un libro intitolato The Roots of Fundamentalism: British and American Millenarianism 1800–1930. Egli propose una tesi cruciale secondo cui la dottrina dell’inerranza biblica nei manoscritti originali fu creata da A. A. Hodge e B. B. Warfield nel loro articolo del 1881 “Inspiration”.
Secondo Sandeen questi due presbiteriani, sentendosi messi a dura prova dai crescenti studi critici del loro tempo, crearono questa dottrina presumibilmente come mezzo per sfuggire alle implicazioni negative che questi studi critici avrebbero avuto sull’autorità della Bibbia. Il professor Sandeen si è sentito di poter affermare che la dottrina dell’inerranza nei manoscritti originali “non esistesse né in Europa né in America prima della sua formulazione nell’ultima metà del XIX secolo”*.
Imputò inoltre alla dottrina di Princeton riguardo la Bibbia inerrante “di essere mantenuta solo grazie al ricorso a manoscritti originali completamente inutili”*. Egli contestava l’affermazione di Hodge e Warfield secondo cui la loro dottrina delle Scritture riflettesse l’insegnamento cattolico delle chiese cristiane fin dall’epoca patristica. Secondo Sandeen, la dottrina dell’inerranza biblica nei manoscritti originali rappresentava un’innovazione dottrinale non euristica, poiché si allontanava tanto dalla Confessione calvinista di Westminster quanto dagli insegnamenti centrali delle Chiese occidentali. Ciononostante i fondamentalisti, dando per scontato che tale credo fosse biblicamente giustificato, si sarebbero appropriati di questa innovazione dottrinale e l’avrebbero convertita in un principio non negoziabile del loro movimento.
Come rispondere a coloro che sostengono l’interpretazione di Sandeen, o altre simili, ovvero che dipingono questa convinzione non come una dottrina della Chiesa evangelica, ma come una formulazione fuorviante dei presbiteriani di fine Ottocento e, in particolare, di A. A. Hodge e B. B. Warfield? Un passaggio logico da compiere è quello di valutare la validità storica della tesi di Sandeen secondo cui la dottrina dell’inerranza nei manoscritti originali non esistesse in Europa o in America prima del 1881 o del 1850.
Ed è proprio a questa impresa che ora mi dedicherò. Come prima cosa presenterò le prove del fatto che la veridicità delle Scritture venne sostenuta da diversi personaggi di spicco della Chiesa cattolica romana (e ne citerò alcuni) sia per quel che concerne le questioni di fede e di pratica, sia per quanto riguarda la storia e la “scienza”. Questi ecclesiastici occidentali contribuirono così a creare una tradizione agostiniana dell’inerranza biblica. Per dimostrare questo punto, offrirò un breve abbozzo di storia della ricezione del modo in cui l’inerranza biblica è stata percepita da questi ecclesiastici. Per storia della ricezione intendo la ricostruzione della storia della percezione degli individui riguardo a una particolare idea, un evento, un fenomeno o un oggetto materiale.
Ad esempio, il professor Sandeen ha fornito ai suoi lettori una certa percezione della storia dell’autorità biblica. La nostra domanda principale sarebbe quindi: la percezione o la ricostruzione storica di Sandeen corrisponde alle opinioni sull’autorità biblica evidenziate dagli ecclesiastici che stiamo portando al banco dei testimoni? Se la tesi di Sandeen fosse valida, prima del 1850 o del 1881 dovremmo aspettarci di non trovare prima nessun sostenitore attendibile dell’inerranza biblica dei manoscritti originali.
In secondo luogo ripercorreremo la stessa storia dell’autorità biblica a partire dall’epoca patristica fino ad arrivare alla fine del XIX secolo, ma questa volta chiameremo al banco dei testimoni un insieme essenzialmente diverso di testimoni e autorità, soprattutto per quanto riguarda le opinioni dei protestanti. Alcuni di questi testimoni non erano sostenitori della dottrina dell’inerranza biblica, tuttavia riconoscevano che tale dottrina fosse centrale nelle Chiese occidentali sia cattoliche che protestanti. Dal momento che provengono da testimoni che non sono sospettati di portare avanti convinzioni circa l’inerranza biblica a causa di una fedeltà ecclesiastica o confessionale, le testimonianze di chi non parteggia per questa causa sono particolarmente ricche di valore.
Agostino sull’inerranza
Iniziamo portando al banco dei testimoni alcune persone che ci aiuteranno a stabilire la premessa secondo cui la convinzione agostiniana nella veridicità delle Scritture costituisse una dottrina ecclesiastica significativa in Occidente (tra i cattolici romani).
Chi meglio di Agostino (354-430) può essere invitato come testimone principale per descrivere l’insegnamento agostiniano sulla veridicità della Scrittura? Dopotutto, come vedremo nella nostra breve storia della ricezione, le opinioni di Agostino sull’infallibilità della Bibbia sono state spesso citate dai teologi successivi e percepite da molti cattolici e protestanti come una dottrina o una tradizione centrale della Chiesa. Hans Küng ha osservato: “L’influenza di sant’Agostino riguardo all’ispirazione e all’inerranza ha prevalso per tutto il Medioevo e fino all’età moderna”*.
Agostino affermava chiaramente, come dottrina ecclesiastica non negoziabile, che non ci sono errori nella Sacra Scrittura. Questo era per lui il suo spazio di lavoro, un guardrail essenziale, se così si può dire. Quando Girolamo, nel suo commento a Galati 2:14, intimò che Paolo si fosse affidato a una “bugia bianca”, Agostino rispose in modo secco, se non allarmistico:
Mi pare infatti che sia quanto mai funesto credere che nei libri Sacri vi sia qualche menzogna; cioè che quegli uomini per opera dei quali è stata redatta e ci è stata trasmessa la Scrittura abbiano detto delle menzogne nei loro libri […] Invero, una volta ammessa una menzogna officiosa in un grado così alto di autorità, non resterà più alcuna parte per quanto esigua di quei libri, la quale, a seconda che sembrerà a ciascuno difficile per la morale o incredibile per la fede, usando lo stesso funestissimo sistema non possa essere riferita ad un preciso intento e ad una esigenza dell’autore che mente.
Qualunque cosa si possa pensare della logica del “o tutto o niente” di Agostino riguardo al significato di un errore, è chiaro che il vescovo di Ippona credesse che la Bibbia fosse “vera” in tutto e per tutto. È senza errori o, se vogliamo, inerrante.
Alcuni contemporanei di Agostino avevano indicato i presunti errori nelle Scritture come base per i loro attacchi alla religione cristiana. In risposta alle loro accuse, Agostino scrisse Il consenso degli Evangelisti. Egli dichiarò che si sentiva obbligato a confutare i miscredenti che negavano l’armonia dei quattro Vangeli e che affermavano l’esistenza di errori nelle Scritture.
E per portare a termine con successo questo progetto, dobbiamo dimostrare che gli scrittori in questione non siano in antagonismo tra loro. Gli oppositori, infatti, hanno l’abitudine di addurre come argomento principale di tutte le loro vane obiezioni questo fatto: che gli evangelisti non siano in armonia tra loro.
Un’altra affermazione di Agostino divenne una componente saliente della dottrina della Chiesa riguardante la veridicità delle Scritture. Nella sua lettera del 405 d.C. a Fausto il Manicheo, Agostino fornì una spiegazione sui modi in cui un lettore avrebbe potuto supporre la presenza di “errori” nelle copie esistenti delle Scritture. Scrisse:
Poiché – debbo confessarlo alla tua Carità – questo timore riverenziale per cui credo in modo fermissimo che nessun autore ha potuto sbagliare nello scrivere, ho imparato ad averlo solamente per i libri della sacra Scrittura. Se quindi m’imbatterò in qualche passo di questi libri, che mi dia l’impressione d’essere in contrasto con la verità, non avrò alcun dubbio che ciò dipenda dal fatto che o è scorretto il manoscritto o il traduttore non ha centrato il senso o sono io che non ho capito.
In sintesi, Agostino qui propone una triplice spiegazione per la provenienza dei presunti errori all’interno delle Scritture. Nel caso si credesse di averne individuato uno, significava o che ci si era imbattuti in un errore nel manoscritto oppure che il traduttore del testo era ricorso ad una traduzione errata o, ancora, semplicemente che era stato frainteso ciò che le Scritture stavano dicendo. Ai tempi di Agostino alcuni studiosi cristiani praticavano una sorta di critica testuale delle Scritture, cercavano cioè di eliminare gli errori dei copisti dalle copie esistenti della Scrittura.
Agostino sosteneva anche che le Scritture fossero scritte in un linguaggio adatto alla debolezza della nostra comprensione. Questo misericordioso accomodamento divino ci aiuta, con le nostre menti fragili, a comprendere le Scritture. Alcuni passi della Scrittura sono scritti nel linguaggio dell’apparenza, vale a dire così come le cose ci appaiono. La Scrittura non è scritta in modo da renderla un testo “scientifico”. Piuttosto, quando descrive il mondo naturale, lo fa in modo veritiero (senza errori), ma non necessariamente in termini esaustivi e troppo accurati.
Negli ambiti evangelici è recentemente emersa una notevole confusione riguardo a ciò che rappresenti la dottrina agostiniana dell’accomodamento, con alcuni studiosi evangelici che ritraggono la dottrina sociniana dell’accomodamento come se fosse una definizione agostiniana. Secondo la definizione sociniana, Dio ha adattato le Scritture alle cosmologie errate degli autori biblici. Il risultato? Una Scrittura errata a causa di errori importati da queste cosmologie difettose che presumibilmente hanno orientato gli scritti degli autori biblici.
Al contrario, la visione agostiniana dell’accomodamento non implicava che nelle Scritture si trovassero errori. La Bibbia può anche descrivere il mondo naturale in modo semplice, ma ciò non toglie che sia veritiero. Richard Muller chiarisce ulteriormente i diversi significati di una visione sociniana dell’accomodamento rispetto a quella agostiniana. Il princetoniano Charles Hodge ha sostenuto che, nella Germania del XIX secolo, è stata la pericolosa difesa di una visione sociniana dell’accomodamento a contribuire all’indebolimento di una visione elevata delle Scritture tra i protestanti.
Eck sull’inerranza
Invitiamo ora al banco dei testimoni il nostro secondo testimone, Johannes Eck (1496-1543), un cattolico romano contemporaneo di Martin Lutero. Nel 1518, Eck si allarmò per il fatto che Erasmo, il brillante classicista cattolico romano e competente biblista, avesse additato Matteo di aver commesso un errore nel sostituire una parola con un’altra. Erasmo fu abbastanza esplicito sul suo punto di vista nel rispondere a Eck: “Né, a mio avviso, l’autorità dell’intera Scrittura sarebbe immediatamente messa a repentaglio, come tu suggerisci, se un evangelista per un errore di memoria mettesse un nome al posto di un altro, Isaia per esempio al posto di Geremia, perché questo non è il fulcro del discorso”*.
Nello stesso passo Erasmo, abile dibattitore, cercò di mettersi al riparo da potenziali accuse di eterodossia sottolineando come non avesse mai detto esplicitamente che nelle Scritture esistesse un vero e proprio errore: “Ciò che vorrei dire non è affatto che gli apostoli abbiano commesso errori, quanto piuttosto negare che la presenza di un qualche errore debba necessariamente scuotere la veridicità dell’intera Scrittura”*.
Ora, Eck, seppur rispettoso della reputazione di Erasmo per la sua erudizione (“il più dotto degli uomini”), non ne voleva sapere di concedere ad Erasmo che in Matteo 2 potessero esserci errori. Era stato Agostino ad aver contribuito alla formazione delle convinzioni di Eck riguardo alla dottrina ecclesiastica delle Scritture. Eck scrisse:
Innanzitutto, tanto per cominciare, sono in molti ad essersi sentiti offesi dal fatto che voi abbiate scritto nelle vostre note sul secondo capitolo di Matteo le parole: “o perché gli stessi evangelisti non hanno tratto prove di questo tipo dai libri, ma, come uomini, si sono affidati alla memoria, commettendo un errore”. Con queste parole, infatti, voi sembrate suggerire che gli evangelisti abbiano scritto come gli uomini comuni, nel senso di aver fatto affidamento sulla loro memoria senza controllare le fonti, e che quindi, per questo motivo, abbiano commesso un errore.*
Poi Eck citò quella che riteneva essere la dottrina agostiniana centrale per la Chiesa per quanto riguardasse l’inerranza biblica: “Ascolta, caro Erasmo: credi forse che ci sia un solo cristiano che sopporterà pazientemente mentre gli si dice che gli evangelisti abbiano commesso degli errori nei loro Vangeli?” Dal punto di vista di Eck, nessun cristiano avrebbe tollerato la presunta dichiarazione di Erasmo circa l’erranza delle Scritture. Successivamente Eck citò quella che era la sua autorità patristica, vale a dire la sua garanzia per questa posizione, nientemeno che l’insegnamento di Sant’Agostino “o tutto o niente”: “Se l’autorità della Sacra Scrittura in questo punto è instabile, può qualsiasi altro passaggio essere esente dal sospetto di errore? Una conclusione tratta da Sant’Agostino da un’elegante catena di ragionamenti”*.
Si noti cosa costituisse un “errore” per Eck: semplicemente una parola sostituita da un’altra. Alcuni critici della dottrina dell’inerranza hanno suggerito che siano stati i princetoniani alla fine del XIX secolo a ridefinire la parola infallibilità, dandole una serie di connotazioni più esigenti e puritane per quanto riguarda ciò che potesse costituire un errore. Una restrizione, quindi, non associata agli usi precedenti della parola infallibilità nella storia della Chiesa. Il dibattito tra Eck ed Erasmo suggerirebbe però il contrario. C’era come minimo Eck a credere che l’infallibilità della Bibbia potesse essere messa in pericolo da una singola parola sbagliata, un piccolo segmento idiomatico.
Simon sull’inerranza
Il nostro terzo testimone ad attestare la potente influenza della dottrina ecclesiastica agostiniana riguardo l’inerranza delle Scritture è Richard Simon (1638-1712). Sacerdote oratoriano, Simon è spesso acclamato come il “padre della critica biblica”. Negli anni del famoso “La crisi della coscienza europea” di Paul Hazard (1680-1715), Simon era probabilmente l’esperto biblico più erudito in tutta Europa. Aveva una profonda conoscenza degli studi rabbinici, della teologia e delle liturgie delle chiese orientali, acquisita in parte durante il suo servizio come bibliotecario presso la casa dell’Ordine degli oratoriani in Rue St. Honoré a Parigi.
Aveva letto e catalogato preziosi manoscritti, sia occidentali che orientali. Aveva acquisito una conoscenza approfondita della storia delle traduzioni della Bibbia e del valore di specifici commentari biblici. Aveva stabilito i principi dell’interpretazione biblica. Ha redatto enormi tomi in cui ha dimostrato una conoscenza non comune della storia dell’esegesi e delle versioni bibliche. Per questi motivi, la testimonianza di Simon circa le convinzioni degli europei all’alba dell’“Illuminismo” europeo è davvero significativa.
Nella prima pagina della sua epocale Histoire critique du Vieux Testament, Simon ha dato una descrizione generale di quelle che nel 1678 erano le convinzioni di cristiani ed ebrei riguardo l’infallibilità della Bibbia:
Non è possibile dubitare che le verità contenute nella Sacra Scrittura siano infallibili e di divina autorità, poiché procedono direttamente da Dio, che per farlo si è servito del ministero degli uomini come suo interprete. C’è forse qualcuno, ebreo o cristiano, che non riconosce che questa Scrittura, essendo la pura Parola di Dio, sia al contempo il primo principio e il fondamento della religione. Ma poiché gli uomini sono stati i depositari dei Libri Sacri, così come di tutti gli altri libri, e poiché i primi Originali [les premiers Originaux] sono andati perduti, era in qualche modo impossibile che non si verificasse un certo numero di cambiamenti, dovuti tanto al tempo trascorso quanto alla negligenza dei copisti. È per questo motivo che Sant’Agostino raccomanda prima di ogni altra cosa a coloro che desiderano studiare la Scrittura di applicarsi alla critica della Bibbia e di correggere gli errori [fautes] delle loro copie. Codicibus emendandis primitus debet invigilare solertia eorum, qui Scripturas Divinas nosse desiderant [Agostino, De doctrina christiana, Libro II]*.
Simon riteneva di essere stato il primo studioso ad applicare il termine francese critique allo studio delle Scritture.
In questo passo, Richard Simon affermava in linea generale che tutti gli ebrei e i cristiani del 1678 credessero nell’autorità divina e nell’infallibilità delle Scritture, poiché esse provenivano da Dio. Simon raccomandava ai critici di correggere gli errori delle loro copie perché gli originaux (originali) erano andati perduti. Inoltre Simon, di formazione gesuita e piuttosto anti-agostiniano, identificava questo programma di “critica testuale” con nientemeno che Agostino.
Anche J. A. Bengel, contemporaneo di Simon, e alcuni studiosi protestanti ortodossi sostenevano la “critica testuale”. Usavano il termine latino autographa per identificare i manoscritti biblici che erano andati perduti e il termine apographa per i testi “originali e autentici” esistenti in greco ed ebraico. Questi ultimi testi erano considerati “infallibili”, e gli eventuali errori erano dovuti ai copisti.
La generalizzazione di Simon secondo cui tutti gli ebrei e i cristiani nel 1678 credessero nell’infallibilità delle Scritture prima dell’inizio del cosiddetto Illuminismo rende meno persuasiva la storiografia che propone l’infallibilità o l’inerranza come dottrine illuministiche, logiche implicazioni di una “religione illuministica” razionalistica. In ogni caso dovremmo forse usare con la dovuta cautela il termine inglese Enlightenment se lo applichiamo al XVIII secolo. L’espressione inglese “Age of Enlightenment” (Età dei Lumi) è entrata in uso solo negli anni Sessanta del XIX secolo, anche se il termine illuminato (Berkeley) ha avuto una certa diffusione già nel linguaggio del XVIII secolo.
Leone XIII sull’inerranza
Il nostro quarto testimone dell’esistenza di una tradizione agostiniana riguardo l’inerranza biblica è Papa Leone XIII, contemporaneo di A. A. Hodge e B. B. Warfield. Il papa voleva insegnare ai professori cattolici romani della Sacra Scrittura del suo tempo il modo in cui avrebbero dovuto studiare la Bibbia e come avrebbero dovuto interagire con la “critica biblica” e con i recenti sviluppi della scienza, e aveva a cuore che tali insegnamenti venissero impartiti in special modo all’interno di “seminari o accademie”.
Il rettore dell’Istituto Cattolico di Parigi, Monseigneur d’Hulst, aveva scritto un articolo (era il 25 gennaio 1893) in cui sembrava aperto a limitare la divina ispirazione delle Sacre Scritture a quelle che sono questioni di fede e di pratica. In Lettera enciclica Providentissimus Deus di Papa Leone XIII, sullo studio della Sacra Scrittura, 18 novembre 1893, Leone XIII specificava come la Chiesa cattolica romana affermasse che la Sacra Scrittura fosse priva di errori non solo riguardo alle questioni di fede e di pratica, ma anche relativamente alle questioni di storia e di scienza (un principio vincolante della dottrina dell’inerranza biblica). Egli rimproverò quanti limitassero l’inerranza delle Scritture a questioni di fede e di morale.
Ma non è assolutamente permesso o restringere l’ispirazione soltanto ad alcune parti della sacra Scrittura, o ammettere che lo stesso autore sacro abbia errato. Infatti non è ammissibile il metodo di coloro che risolvono queste difficoltà non esitando a concedere che l’ispirazione divina si estenda alle cose riguardanti la fede e i costumi, e nulla più, stimando erratamente che, trattandosi del vero senso dei passi scritturali, non tanto sia da ricercarsi quali cose abbia detto Dio, quanto piuttosto il soppesare il motivo per cui le abbia dette.
Riguardo alla scienza fisica, Papa Leone XIII scrisse:
Bisogna combattere […] coloro che, abusando della propria scienza di fisici, indagano in ogni modo i Libri sacri, per rimproverare agli autori la loro imperizia in tali cose, e trovano da ridire sugli stessi scritti. Queste accuse, riguardando le cose oggetto dei sensi, diventano perciò stesso più pericolose, diffuse tra il popolo, e soprattutto tra i giovani studenti.
Leone XIII continuò: “Nessuna vera contraddizione potrà interporsi tra il teologo e lo studioso delle scienze naturali, finché l’uno e l’altro si manterranno nel propri confini, guardandosi bene, secondo il monito di sant’Agostino”, e citò poi il saggio consiglio di Agostino:
Tutto ciò che i fisici, riguardo alla natura delle cose, potranno dimostrare con documenti certi, è nostro compito provare non essere nemmeno contrario alle nostre Lettere; ciò che poi presentassero nei loro scritti di contrario alle nostre Lettere e cioè contrario alla fede cattolica, o dimostriamo con qualche argomento essere falso ciò che asseriscono o crediamolo falso senza alcuna esitazione.
Papa Leone XIII riconosceva che la Vulgata fosse la versione “autentica” della Chiesa cattolica romana secondo il Concilio di Trento. Tuttavia citò il consiglio di Agostino secondo cui “l’esame accurato della lingua originale” e dei manoscritti sarebbe utile e vantaggioso “se un qualche punto [della Vulgata] riuscisse un po’ oscuro o fosse stato tradotto meno accuratamente”.
Verso la fine della sua enciclica, Leone XIII riassunse così l’insegnamento cattolico sull’inerranza biblica. Si riferiva ad un passo di Agostino che abbiamo già citato come garanzia di questa dottrina della Chiesa:
Ne viene di conseguenza che coloro che ammettessero che nei luoghi autentici dei sacri Libri possa trovarsi alcun errore, costoro certamente o pervertono la nozione cattolica della divina ispirazione o fanno Dio stesso autore dell’errore. Tutti i padri e dottori erano talmente persuasi che le divine Lettere, quali furono composte dagli agiografi, sono assolutamente immuni da ogni errore, che non pochi di quei passi che sembrano presentare qualcosa di contrario e di dissimile (e cioè quasi i medesimi che ora vengono proposti come obiezioni sotto il nome della nuova scienza) cercarono non meno sottilmente che religiosamente di comporli e conciliarli tra loro, […] Valga per tutti ciò che lo stesso Agostino scriveva a Girolamo: “Io, infatti, confesso alla tua benevolenza che soltanto al libri delle Scritture, che già vengono chiamati canonici, ho imparato a prestare una tale venerazione e onore, da credere fermissimamente che nessuno dei loro autori abbia commesso errore alcuno nello scrivere. Qualora poi, mi imbattessi in essi in qualche cosa che sembrasse contrario alla verità, non avrò il minimo dubbio che ciò dipenda o dal codice difettoso, o dal traduttore che non ha interpretato rettamente ciò che fu scritto, o che la mia mente non è arrivata a capire”
Si noti che Papa Leone XIII riteneva che i padri della Chiesa avessero lottato con alcuni degli stessi passaggi problematici che avevano attirato l’attenzione dei “critici biblici” dei suoi tempi. Leone XIII aveva chiaramente la percezione che ciò che intendeva dire affermando che la Sacra Scrittura fosse senza errori corrispondesse a ciò che i padri della Chiesa credevano circa la veridicità delle Scritture. Non pensava di vivere in un paradigma (termine nostro) diverso dal loro al punto da non poter comprendere i problemi testuali da loro affrontati. Inoltre Leone XIII confermò la premessa secondo cui nella Chiesa cattolica romana l’insegnamento di Agostino sull’inerranza della Bibbia equivalesse a una dottrina centrale della Chiesa.
Si noti anche che le affermazioni di Hodge e Warfield nel 1881 sull’infallibilità dei manoscritti originali come dottrina della Chiesa appaiono molto meno solitarie e dottrinalmente innovative nel contesto dell’enciclica di Leone XIII (1893). E se mai dovessimo chiederci se Leone non avesse preso in prestito il suo pensiero riguardante le Scritture da Hodge e Warfield, che avevano scritto un decennio prima di lui, possiamo tranquillamente supporre che non l’abbia fatto. Il papa stava piuttosto ribadendo la dottrina ecclesiastica agostiniana sull’inerranza.
I più recenti sviluppi cattolici
Nel 1910 il papato cercò di arginare gli insegnamenti dei cosiddetti “modernisti cattolici” (termine usato per la prima volta nel 1905) stabilendo che tutti i membri del clero dovessero prestare un giuramento antimodernista. I “modernisti” cattolici, come Alfred Loisy dell’Istituto Cattolico di Parigi, avevano già tentato di rendere più accettabili, all’interno della Chiesa cattolica romana, gli insegnamenti della critica biblica e della teoria dell’evoluzione. Essi negavano l’inerranza delle Scritture. Il papato respinse categoricamente le iniziative dei modernisti e continuò ad affermare la dottrina ecclesiastica dell’inerranza biblica.
Alcuni anni dopo, Papa Pio XII, nella sua enciclica Divino Afflante Spiritu (1943), condannò ancora una volta la posizione dell’inerranza limitata (cioè l’esclusione della storia e della scienza dalla definizione di inerranza). Il papa scrisse che
anche dopo, in contrasto con questa solenne definizione della dottrina cattolica, la quale ai Libri “interi con tutte le loro parti” rivendica tale autorità divina, che va esente da qualunque errore, alcuni autori cattolici non si peritarono di restringere la verità della Sacra Scrittura alle sole cose riguardanti la fede e i costumi, e di considerare le rimanenti, sia di scienze naturali sia di storia, come “dette alla sfuggita” e senza alcuna connessione, secondo loro, con le verità di Fede. Perciò il Nostro Predecessore di immortale memoria Leone XIII, con l’Enciclica “Providentissimus Deus” […] inflisse a quegli errori la ben meritata condanna.
All’inizio degli anni Sessanta i redattori della prima edizione della Dei Verbum, la dichiarazione di Vaticano II sulle Sacre Scritture, continuarono ad affermare la dottrina dell’inerranza biblica per le questioni tanto di fede e di pratica quanto di storia e di scienza. Tuttavia, nell’edizione finale (18 novembre 1965) della Dei Verbum (la Costituzione sulla Divina Rivelazione, art. 11), la Chiesa cattolica romana in Vaticano II ruppe apparentemente con la propria definizione agostiniana di inerranza e affermò: “bisogna ritenere […] che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre Scritture”.
In seguito alcuni studiosi cattolici hanno iniziato a identificare la posizione dell’inerranza (comprendente la storia e la scienza) non con la tradizione agostiniana di lunga data della loro Chiesa, ma, cosa interessante, con il punto di vista del fondamentalismo protestante e del letteralismo biblico. Ad esempio l’arcivescovo di Denver Charles J. Chaput, nel suo discorso alla Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti (2000), ha intitolato il suo intervento “Dei Verbum 35 Years Later: Understanding the Word of God” (letteralmente, “Dei Verbum 35 anni dopo: Comprendere la Parola di Dio”, italiano non reperibile o non disponibile, N.d.T.) e ha dichiarato:
Nell’interpretazione della Bibbia, il Dei Verbum offre quindi una via di mezzo tra il fondamentalismo protestante e il razionalismo secolare. Insegna chiaramente l’ispirazione divina degli autori sacri e quindi l’inerranza dei loro scritti. Dice “che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre Scritture” (n. 11). In questa frase qualificante, “per la nostra salvezza”, sentiamo la risposta cattolica al razionalismo moderno, che nega l’inerranza delle Scritture e persino la necessità della salvezza. Ma il Dei Verbum evita anche un letteralismo semplicistico.*
Occasionalmente alcuni studiosi cattolici romani hanno osato sollevare l’obiezione che ciò che alcuni loro colleghi hanno denigrato come una visione fondamentalista delle Scritture rappresenti in realtà ciò che la Chiesa cattolica romana ha essenzialmente insegnato riguardo alle Scritture dai tempi di Agostino fino alla prima stesura della Dei Verbum di Vaticano II.
Punti di vista protestanti: James Kugel
Nel segmento precedente del nostro abbozzo della storia della ricezione abbiamo suggerito che, contrariamente alla percezione del professor Sandeen della storia dell’autorità biblica, la dottrina dell’inerranza biblica costituisse una dottrina ecclesiastica agostiniana centrale per la Chiesa cattolica romana fino al Vaticano II. Certo, nella comunione cattolica romana c’erano biblisti e teologi come Erasmo, Lessius, Isaac de La Peyrère, Henry Holden, Richard Simon, Lammenais e il “modernista” cattolico Alfred Loisy che dissentivano dalla dottrina in un modo o nell’altro, ma costituivano una netta minoranza all’interno del clero.
Ma la dottrina ecclesiastica agostiniana dell’inerranza delle Scritture costituiva una convinzione ecclesiale anche per i protestanti d’Occidente? Per rispondere a questa domanda cercheremo ancora una volta di tracciare la storia della ricezione della dottrina dell’inerranza biblica in relazione ai protestanti.
I riformatori protestanti, da Martin Lutero a Thomas Cranmer, ritenevano che fino circa al 1200, cioè durante l’epoca patristica e oltre, la Chiesa cristiana fosse rimasta sostanzialmente ortodossa, e che quindi appartenesse a loro retaggio. Cranmer, ad esempio, sosteneva che la Chiesa cattolica avesse rispettato la vera dottrina della Cena del Signore fino all’anno 1000 circa, ma che poi l’insegnamento della Chiesa si fosse corrotto.
I Riformatori credevano di recuperare la dottrina della Chiesa, non di inventarla. Il nostro primo testimone è James L. Kugel, esperto della Bibbia ebraica e della sua interpretazione. La sua testimonianza fornisce ulteriori spunti di riflessione sul modo in cui i padri della Chiesa stimavano e veneravano le Scritture. Ci aiuta a capire che, nonostante i padri della Chiesa non avessero trattato il tema dell’inerranza in modo sistematico, avevano lavorato con questo presupposto nella loro esegesi.
Dal 1982 al 2003 il professor Kugel, che ora vive in Israele, è stato professore di ebraico ad Harvard. Il suo corso sulla Bibbia attirava fino a novecento studenti, uno dei corsi più popolari dell’università.
Nel suo recente libro How to Read the Bible: A Guide to Scripture Then and Now, Kugel sostiene che i padri della Chiesa credessero le Scritture prive di errori e che si impegnassero in tentativi di armonizzazione per dimostrare che fosse così. Kugel scrive: “È un fatto sorprendente che tutti gli interpreti antichi sembrino aver condiviso più o meno la stessa serie di aspettative sul testo biblico”*. E continua:
Possiamo avere un quadro piuttosto chiaro di ciò che i loro autori credessero riguardo al testo biblico, e ciò che emerge è che, nonostante la distanza geografica e culturale che separava alcuni di questi interpreti da altri, tutti sembrano aver presupposto gli stessi quattro fondamenti riguardanti come la Bibbia debba essere letta”*.
Kugel delinea quindi quattro assunti comuni agli interpreti antichi. Stando al terzo assunto del suo elenco, i padri della Chiesa sostenevano la perfetta veridicità delle Scritture. L’assunto 3 recita: “Gli interpreti presumevano anche che la Bibbia non contenesse contraddizioni o errori. Essa è perfettamente armoniosa, nonostante sia un’antologia…”* Kugel osserva inoltre:
E naturalmente la Bibbia non deve contraddirsi o sembrare ripetersi inutilmente, per cui se dice due volte “e i due camminavano insieme”, la seconda ricorrenza non può essere semplicemente ripetitiva, ma deve significare qualcosa di diverso dalla prima. In breve la Bibbia, secondo loro, è un libro assolutamente coerente, uniforme, perfetto.*
Ora, il professor Kugel non è affatto un sostenitore della dottrina dell’inerranza biblica. Non è quindi così facile impugnare la sua testimonianza come se derivasse da uno spirito di parte.
Lutero, Calvino e gli ortodossi protestanti
Alla vigilia della Riforma, Johannes Eck, come abbiamo visto, sosteneva che “nessun cristiano” avrebbe permesso a Erasmo di affermare che nella Scrittura esistesse un vero e proprio errore. Ma anche Martin Lutero, contemporaneo di Eck e a volte suo contestatore, credeva nell’inerranza biblica? Su questo argomento controverso è stato versato molto inchiostro.
Heimo Reinitzer, il nostro secondo testimone, può aiutarci a giudicare la validità delle contrastanti interpretazioni del punto di vista di Lutero sull’autorità biblica. Nel 1983 il dottor Reinitzer ha pubblicato Biblia deutsch: Luthers Bibelübersetzung und ihre Tradition (letteralmente, Biblia deutsch: traduzione e tradizione della Bibbia di Lutero; testo italiano non disponibile, N.d.T.), in occasione del cinquecentesimo compleanno di Lutero. Nella ricerca portata avanti per redigere questo libro, Reinitzer, in quanto storico, ha studiato la storia delle varie edizioni della Bibbia di Lutero (1534) e il punto di vista del riformatore sull’autorità e sull’interpretazione delle Scritture. Reinitzer è tra i maggiori esperti al mondo circa la visione di Lutero sull’autorità biblica.
All’inizio degli anni Ottanta ero ricercatore presso la Herzog August Bibliothek di Wolfenbüttel, in Germania, più o meno nello stesso periodo in cui il libro del professor Reinitzer veniva pubblicato con il patrocinio della biblioteca. Anche Reinitzer svolgeva occasionalmente delle ricerche presso la biblioteca. Ho avuto l’opportunità di fare alcune “pause caffè” insieme a lui. I tedeschi amano parlare davanti a un caffè e il dottor Reinitzer, austriaco di nascita, non faceva eccezione.
Sapendo che una notevole controversia aleggiava sulla questione di ciò che Lutero credesse della Scrittura, chiesi a Reinitzer quale fosse, secondo lui, la visione di Lutero riguardo all’autorità biblica. Ad esempio, Lutero credeva nell’inerranza biblica? La risposta di Reinitzer è stata diretta: “Certamente”, rispose. Poi mi diede una breve lezione di storia su come si fosse diffusa l’idea che Lutero non credesse nell’inerranza biblica. Dal suo punto di vista, alcuni storici e teologi neo-ortodossi avevano creato e promosso questa storiografia fuorviante. Questi hanno spesso sostenuto che esistesse una discrepanza tra la visione di Lutero dell’autorità biblica, con il suo focus cristologico, e le opinioni dei luterani successivi chiamati “accademici” o “ortodossi protestanti”.
Olivier Fatio dell’Università di Ginevra ha sostenuto la stessa tesi della continuità di fede tra Giovanni Calvino e gli ortodossi riformati. Lui e altri, come Jill Raitt, hanno contestato in particolare la storiografia neo-ortodossa di Ernst Bizer a sostegno del fatto che Lambert Daneau fosse il primo teologo riformato a tradire il punto di vista di Calvino, introducendo un approccio razionalistico alla teologia e includendo il mondo naturale nell’ambito dell’autorità della Bibbia.
È interessante notare che anche Richard Muller, in accordo con Reinitzer e Fatio, sostiene che tra Lutero e Calvino e gli ortodossi protestanti del XVII secolo esistesse una continuità di pensiero circa l’infallibilità della Bibbia. Muller aggiunge che anche i teologi cattolici prima della Riforma sostenessero la stessa dottrina. Nel suo studio enciclopedico Post-Reformation Reformed Dogmatics: The Rise and Development of Reformed Orthodoxy, ca. 1520 to ca. 1720, Muller scrive:
Similmente la caratterizzazione spesso sentita della visione ortodossa della Scrittura, secondo cui il protestantesimo avrebbe rifiutato un infallibile papa romano solo per sostituirlo con un infallibile “papa di carta”, è, nella migliore delle ipotesi, un malinteso della storia della dottrina della Scrittura. Da un lato si ignora la continuità della dottrina cristiana su questo punto: l’insegnamento cattolico prima della Riforma presupponeva l’infallibilità della Scrittura, e i Riformatori non hanno fatto niente di diverso – gli ortodossi protestanti non hanno inventato questo concetto.
[…]
La dottrina dell’autorità infallibile della Scrittura rimase una costante, mentre il quadro dell’interpretazione si spostò da una forte enfasi posta sul magistero ecclesiastico e sulla tradizione a un’enfasi altrettanto forte posta sulle norme confessionali e su una tradizione di interpretazione più strettamente definita. Il dibattito centrale non riguardava l’infallibilità della Scrittura – che era data per scontata da entrambe le parti – ma era bensì incentrato sulla questione dell’autorità, in particolare sull’autorità dell’interpretazione.*
William Whitaker
L’analisi storica del professor Muller è ampiamente confermata da uno degli scambi polemici più significativi della fine del XVI secolo, quello tra il professore protestante di Cambridge William Whitaker e il celebre teologo cattolico romano Roberto Bellarmino. Nella sua Disputatio de Sacra Scriptura, contra Papistas, praecipue Bellarminum et Stapletonum (1588), Whitaker mostrava come i protestanti sostenessero l’inerranza delle Scritture come dottrina della Chiesa:
Ma, dicono [i cattolici romani], la Chiesa non sbaglia mai; il Papa non sbaglia mai. Daremo adeguata dimostrazione del fatto che entrambe le affermazioni siano false. Noi diciamo che la Scrittura non sbaglia mai, e quindi giudichiamo più vera l’interpretazione che concordi con quanto dice la Scrittura. Che cosa abbiamo a che fare con le chiese, i concili o i papi, a meno che non dimostrino che ciò che definiscono sia in armonia con le Scritture?*
Come i cattolici prima di lui, il protestante Whitaker rivendicava l’insegnamento di Agostino sulle Scritture come una garanzia essenziale per la sua fede nell’inerranza:
Non possiamo che disapprovare totalmente l’opinione di quanti pensano che gli scrittori sacri siano, in alcuni punti, caduti in errore. Che alcuni degli antichi fossero di questa opinione appare dalla testimonianza di Agostino, che sostiene, in opposizione a quelli, che sia “tuttavia conveniente escludere nei racconti evangelici ogni sorta di falsità: non solo quindi quella che si commette mentendo ma anche quella che consiste nel dimenticare una cosa” (Il Consenso degli Evangelisti, Libro II, cap. 12). Di conseguenza Girolamo giudicava male, se davvero riteneva, come suppone Erasmo, “che gli evangelisti potessero essere caduti in un errore di memoria”*.
Come il cattolico romano Eck, Whitaker criticò in particolar modo la concessione di Erasmo secondo cui Matteo potesse aver commesso un errore. Whitaker scrisse: “Ma non è il caso di essere così semplici e indulgenti da concedere che un tale errore possa essere accaduto agli scrittori sacri”*.
Nella sua Critical History of the Old Testament (1678), Richard Simon descrive la Disputatio de Sacra Scriptura di Whitaker come un apologo protestante “chiave” sull’autorità biblica:
Ho inoltre approfondito i sentimenti che Whitaker nutriva nei confronti di Bellarmino e degli altri gesuiti, perché questo dovrebbe servire come chiave di lettura per comprendere gli innumerevoli libri che sono stati scritti in seguito dai protestanti di Francia, Inghilterra e Germania contro i libri di Bellarmino.*
Secondo Simon, numerosi teologi protestanti in Europa ricorrevano alla Disputatio de Sacra Scriptura di Whitaker quando avevano bisogno di argomenti da usare nelle dispute con i polemisti cattolici.
Simon è stato l’ultimo grande pensatore d’Occidente a chiedersi, senza apparire avventato, se ci sia “qualcuno, ebreo o cristiano, che non riconosca che questa Scrittura, essendo la Parola di Dio, è allo stesso tempo il primo principio e il fondamento della religione”*. In altre parole, Simon indicò che già nel 1678 la maggior parte di coloro che si identificavano come cristiani e ebrei affermava, e cito il sacerdote, che “le verità contenute nella Sacra Scrittura sono infallibili e di autorità divina, poiché provengono immediatamente da Dio, che nel fare questo si è servito del ministero degli uomini come suoi interpreti”.*
L’inerranza: tra contestazione e difesa
Ma durante la cosiddetta “crisi della coscienza europea” di Paul Hazard (1680-1715), un buon numero di illustri studiosi appartenenti alla Repubblica delle Lettere iniziò a mettere in discussione la posizione dell’inerranza, esattamente come alcuni scettici, deisti, sociniani e altri avevano fatto prima di loro. Tra queste figure di spicco della vita intellettuale europea vi erano Pierre Bayle, Jean Le Clerc e John Locke. Già negli anni Cinquanta del XVI secolo Isaac de La Peyrère aveva proposto l’ipotesi preadamitica, ossia l’esistenza di preadamiti vissuti prima di Adamo ed Eva. Alcune prove suggerivano che la Groenlandia potesse già essere stata abitata cinquantamila anni prima.
Questa ipotesi mise in discussione i calcoli di numerosi cronologi biblici del XVII secolo, e che Anthony Grafton dell’Università di Princeton sta attualmente studiando. James Ussher (1581-1656) fu uno dei più famosi cronologi. Ussher aveva stimato la data della Creazione nel 4004 a.C. L’ipotesi di La Peyrère fu percepita dai cattolici e dai protestanti ortodossi come una sfida diretta alla visione tradizionale dell’infallibilità biblica e al chiaro insegnamento della Genesi. Trascinato davanti all’Inquisizione cattolica romana, La Peyrère ritrattò il suo punto di vista, incolpando la sua precedente formazione calvinista di averlo portato fuori strada.
Lo storico Richard Popkin sostenne con forza che fu il caso di La Peyrère, piuttosto che la controversia su Galileo (Galileo dichiarò di credere nell’infallibilità biblica), a dare il via a un primo round della cosiddetta guerra tra scienza e religione.
Simon, un corrispondente con La Peyrère, fu anche accusato di aver rovesciato la dottrina dell’infallibilità biblica, proprio quella che aveva affermato essere sostenuta da “tutti i cristiani e gli ebrei”. Nella prefazione alla Histoire critique du Vieux Testament, Simon propose la sua controversa “ipotesi degli scribi pubblici”, cioè che la repubblica di Israele avesse scribi pubblici che tenevano i registri di Israele.
Questi scribi, presumibilmente sotto l’ispirazione dello Spirito Santo e utilizzando i documenti di Israele, avrebbero aggiunto degli emendamenti al Pentateuco. Di conseguenza, secondo Simon, Mosè non scrisse tutto il Pentateuco. L’ipotesi di Simon era ritenuta così pericolosa che il governo francese, su sollecitazione di Bossuet, ordinò di bruciare le milletrecento copie della prima edizione della Histoire critique du Vieux Testament di Simon. L’Ordine Oratoriano cui Simon apparteneva espulse prontamente il sacerdote.
Per ironia della sorte, nella prefazione alla sua controversa opera Simon sosteneva di sperare che la sua “ipotesi degli scribi pubblici” avrebbe contribuito a rispondere alle gravi obiezioni che Spinoza aveva sollevato sulla paternità mosaica del Pentateuco nel suo Trattato Teologico-Politico (1670). Qualche anno più tardi Simon e il Rimostrante Jean Le Clerc si scontrarono in uno dei più famosi dibattiti della storia europea (1685-1687) riguardante l’infallibilità delle Scritture e la paternità del Pentateuco. In questa accesa contesa, Le Clerc scrisse due libri e Simon tre. I due studiosi si confrontarono in francese piuttosto che in latino, la lingua normalmente scelta per discutere di questioni teologiche delicate.
Per molti aspetti, il dibattito Simon-Le Clerc rappresentò un punto di svolta nella storia intellettuale europea. Costituì l’ultimo dibattito significativo seguito dai maggiori intellettuali europei che ancora riflettessero seriamente sulle pretese di infallibilità della Bibbia. A metà del XVIII secolo, studiosi che vanno dal critico biblico Jean Astruc al filosofo Diderot, editore dell’Encyclopédie, citavano il dibattito Simon-Le Clerc come una controversia molto significativa attorno all’autorità della Bibbia.
Del resto Johann Salomo Semler, il cosiddetto “padre della critica biblica” di Halle, in Germania, scrisse nel suo diario che fu dopo aver letto le opere di Simon e Le Clerc che si sentì costretto a rivedere le sue opinioni riguardanti l’autorità della Bibbia. Semler era cresciuto tra i pietisti tedeschi, molti dei quali non solo avevano sostenuto l’inerranza delle Scritture, ma, come il suo collega John David Michaelis all’Università di Halle, avevano persino difeso l’infallibilità dei testi masoretici (1739).
Negli anni Venti del XVII secolo, un buon numero di pastori e professori pietisti di Halle aveva difeso sia l’infallibilità del “testo volgare” sia l’infallibilità dei testi masoretici. Nella Allgemeine Bibliothek Johann Gottfried Eichhorn, noto critico biblico, scrisse:
Una Bibbia che ha goduto di numerose letture è stata stampata ad Halle nell’anno 1720 e, nonostante l’uso del nobile dispositivo, essi si attenevano ancora con ostinazione all’infallibilità del testo volgare […] Avevano scoperto indagando, ed avevano di fronte a loro ben esposto alla vista in questa edizione della Bibbia, le contraddizioni della Masora, la prova più soddisfacente della loro fallibilità, e tuttavia avevano giurato, in modo altrettanto solenne, sull’assoluta infallibilità della stessa, come avevano giurato sui loro articoli simbolici.*
L’influente opinione secondo cui i pietisti tedeschi in generale non abbracciassero l’inerranza biblica deve essere riesaminata. A Losanna alcuni protestanti si scontrarono per strada per i testi masoretici, alcuni a favore della sua infallibilità, altri contrari.
Coleridge, Sabatier e Huxley
La testimonianza del nostro prossimo testimone, il famoso letterato inglese Samuel Taylor Coleridge, ci aiuterà a capire quali fossero le convinzioni dei protestanti inglesi non molti decenni prima che A. A. Hodge e B. B. Warfield scrivessero il loro articolo del 1881, “Ispirazione”. Nel suo postumo Confessions of an Inquiring Spirit (1841) Coleridge, intenzionato ad abbattere la convinzione nell’infallibilità della Bibbia, citò l’affermazione di uno scettico secondo cui la maggior parte dei protestanti inglesi, metodisti, calvinisti, quaccheri o altri che fossero, credesse nell’infallibilità biblica:
Ho partecipato spesso alle riunioni della British and Foreign Bible Society, dove ho ascoltato oratori di ogni denominazione, calvinisti e arminiani, quaccheri e metodisti, ministri ed ecclesiastici dissenzienti, nonché dignitari della Chiesa stabilita, e ho sentito sempre la stessa dottrina, cioè che riguardo alla Bibbia non si sarebbero dovute fare considerazioni o discussioni come quelle che possono essere fatte per altri libri. […] Per di più le loro argomentazioni principali si basavano sulla convinzione che la Bibbia fosse stata dettata dall’Onniscienza, e che quindi in tutte le sue parti fosse infallibilmente vera e imprescindibile, e che gli uomini, con i cui nomi si sono intitolati i vari libri o capitoli, non fossero in realtà che penne diverse nella mano di uno stesso Scrittore, e le parole le parole di Dio stesso.*
Coleridge rispose: “Cosa potrei rispondere a tutto questo? Non potrei né negare il fatto, né eludere la conclusione, cioè che questa è attualmente la convinzione popolare”*. Secondo Coleridge, l’attaccamento all’infallibilità della Bibbia rimase una dottrina ecclesiastica fondamentale per la maggior parte dei protestanti inglesi almeno fino agli anni Trenta del XIX secolo.
Un altro testimone pertinente è Louis Auguste Sabatier (1839-1901), uno degli astri lucenti del liberalismo protestante. Contribuì a fondare la Facoltà protestante di teologia di Parigi e ne fu il preside. La sua testimonianza ci aiuta a comprendere che, nonostante l’impatto del siècle des Lumières (Illuminismo) del XVIII secolo sulla cultura francese, molti protestanti francesi e svizzeri del XIX secolo rimasero fedeli alla dottrina dell’infallibilità della Bibbia fino agli anni ’40.
Duro critico della dottrina, Sabatier, nel suo postumo The Religions of Authority and the Religion of the Spirit (1901), sosteneva che “Richard Simon, Jean Le Clerc, Lessing, Semler e i teologi tedeschi del XIX secolo” avessero attaccato aspramente la dottrina. Sabatier affermava che la “crisi ultima” della dottrina nel mondo protestante francese si fosse verificata tra il 1848 e il 1860, precipitando, in parte, quando il professor Edmond Scherer della scuola teologica L’Oratoire di Ginevra, non potendo più sottoscrivere in coscienza la dottrina della scuola evangelica, si era dimesso nel 1849.
Il professor Sabatier osservò che alcuni teologi del suo tempo (anni ’70-’90 del XIX secolo), incapaci di sostenere “il carattere assoluto dell’infallibilità della Bibbia senza il quale l’infallibilità non esiste”*, cercavano di difendere “una sorta di infallibilità indefinita e limitata, un’infallibilità fallibile che è semplicemente impossibile definire”*. Il loro impegno strategico, secondo lui, era destinato a fallire.
L’ultimo testimone è Thomas Huxley (1825-1895), noto difensore di Darwin. Huxley sosteneva che il tratto intellettuale più importante del suo tempo fosse l’emergere dell’autorità della “conoscenza naturale” in sostituzione all’autorità della “conoscenza rivelata”. Nel 1869 aveva “inventato la parola ‘agnostico’ per indicare le persone che, come [lui], si confessano irrimediabilmente ignoranti riguardo a una serie di questioni sulle quali i metafisici e i teologi, sia ortodossi che eterodossi, dogmatizzano con la massima sicurezza”*. Nel 1893, Huxley, come Coleridge prima di lui, riconobbe che la grande maggioranza del popolo inglese avesse creduto nell’infallibilità biblica nei decenni precedenti:
La dottrina dell’infallibilità biblica era ampiamente sostenuta dai miei connazionali, se non ricordo male: ho ragione di pensare che molte persone di ineccepibile devozione, alcune di cultura e persino alcune di intelligenza, la sostengano ancora. Ma mi permetto di dubitare che da essa possa scaturire un gran sostenitore la cui competenza e autorità siano riconosciute al di là dei limiti della setta o del gruppo teologico a cui appartiene.*
Huxley notò che, proprio come nella Francia di Sabatier degli anni Novanta del XIX secolo, anche in Inghilterra era in corso uno sforzo apologetico volto a mantenere il nome di “Ispirazione” per suggerire la fonte divina, e di conseguenza l’infallibilità, di una parte più o meno consistente della letteratura biblica, svuotando però accuratamente il termine di ogni senso definito. Viene fondamentalmente chiesto di sostituire l’“ispirazione plenaria” con una sorta di “ispirazione a responsabilità limitata”, il cui limite è suscettibile di fluttuazioni indefinite in corrispondenza delle esigenze della critica scientifica.
Come Sabatier, Huxley credeva che questo stratagemma avrebbe fallito.
Riflessioni: l’identità evangelica e la dottrina dell’inerranza biblica
La dottrina dell’inerranza biblica non è una creazione tardiva e fantasiosa di A. A. Hodge e B. B. Warfield nel 1881 o del fondamentalismo americano del XX secolo. È piuttosto una convinzione evangelica essenziale basata su una garanzia biblica. Si colloca perfettamente all’interno della tradizione agostiniana per quanto riguarda la veridicità della Bibbia. Sia i cattolici romani che i riformatori protestanti sostennero questa dottrina della Chiesa.
Non c’è da stupirsi, quindi, che Hodge e Warfield, pienamente consapevoli della provenienza storica della dottrina (dai Padri antecedenti a Nicea, al cattolicesimo romano e fino al protestantesimo), l’abbiano descritta come la “grande dottrina cattolica dell’ispirazione biblica, vale a dire, quindi, che le Scritture non contengono semplicemente la Parola di Dio, ma sono Esse Stesse Parola di Dio. Ne consegue che tutti i loro elementi e tutte le loro affermazioni sono assolutamente senza errori, vincolando così la fede e l’obbedienza degli uomini”*. Hanno poi definito la loro visione come una dottrina della Chiesa e hanno osservato:
È indubbio che le grandi Chiese storiche abbiano tenuto queste definizioni di credo nel senso di affermare l’infallibilità priva di errori della Parola. Ne è presente grande dimostrazione nel modo in cui tutti i più grandi esponenti tra i teologi protestanti abbiano trattato la Scrittura nei loro commentari, nella loro teologia sistematica, nei loro catechismi e sermoni. E questa è sempre stata una caratteristica predominante delle epoche e dei protagonisti della riforma. È così che tutti i grandi uomini che hanno mosso il mondo, come Lutero, Calvino, Knox, Wesley, Whitefield, Chalmers e chi come loro, hanno trattato la Parola divina.*
Tra le confessioni a sostegno dell’“infallibilità priva di errori”, hanno citato il Concilio romano-cattolico di Trento, la Confessione di Westminster e la Seconda Confessione Elvetica. Le nostre storie di ricezione danno credito alle loro affermazioni.
Per contro, la percezione di Ernest Sandeen della storia dell’inerranza biblica potrebbe necessitare di una sostanziale revisione. La dottrina dell’inerranza biblica non è stata creata negli ultimi decenni del XIX secolo. Sono stati piuttosto i modernisti cattolici e i protestanti in Europa, come quelli citati da Sabatier e Huxley, che hanno cercato di modificare o di eliminare questa dottrina.
In più, lo storico Clinton Ohlers ha studiato il pensiero di alcuni studiosi protestanti americani che avevano abbandonato la dottrina dell’inerranza all’inizio del XX secolo. Questi avevano spesso la percezione di aver abbandonato la vecchia visione protestante ortodossa delle Scritture. In molti usavano inoltre i termini infallibilità e inerranza in modo intercambiabile. Per esempio Charles W. Pearson (1846-1905), professore di letteratura inglese alla Northwestern University e i cui attacchi all’inerranza biblica nel 1902 ricevettero un’ampia copertura giornalistica, fece proprio questo. Il presidente della Northwestern University gli chiese di dimettersi dal suo incarico.
Per quanto riguarda la dottrina dell’infallibilità dei manoscritti originali, si trattava di un teologico elemento di arredo comune tra i teologi evangelici del XIX secolo, come ha dimostrato lo storico Randall Balmer nella sua tesi di laurea. Proprio a Princeton nel 1825 Charles Hodge, predecessore di Warfield e redattore del Biblical Repertory, inserì in questa rivista rivista un articolo del professore tedesco C. Beck.
Beck fa una chiara distinzione tra i manoscritti originali perduti e le copie esistenti delle Scritture. Scrive: “I manoscritti sembrano essere periti presto, e le copie che sono state prese sono diventate più o meno soggette a quegli errori che derivano dalle sviste dei trascrittori, dalle false correzioni dei commentatori e dei critici, dalle note marginali e da altre fonti”*.
Hodge e Warfield non erano affatto innovativi dal punto di vista teologico nel parlare dei manoscritti originali nell’articolo “Ispirazione” del 1881. Al contrario, stavano ribadendo un assunto comune della critica testuale biblica che Richard Simon e altri avevano articolato e associato al programma di Agostino per la correzione degli errori nelle copie esistenti delle Scritture. Hodge e Warfield hanno posto la questione in questi termini: le Scritture sono prive di errori “quando gli ipsissima verba [parole stesse] dei manoscritti originali sono accertati e interpretati nel loro senso naturale e voluto”*. I manoscritti originali potrebbero essere compresi attraverso un attento lavoro testuale. Non sono “inutili”, come invece sosteneva Sandeen.
Prima del 1881 innumerevoli cattolici romani e protestanti evangelici ritenevano che la Bibbia fosse infallibile non solo per le questioni di fede e di pratica, ma anche per quelle di storia e scienza. L’insegnamento di Agostino a questo proposito equivaleva a una dottrina ecclesiastica basilare per molti cattolici e protestanti. Alcuni sostenevano che questa convinzione derivasse direttamente dalla premessa che Dio, autore della verità, fosse anche l’autore ultimo delle Sacre Scritture. Pertanto le Scritture sono prive di errori. Molti ritenevano che la dottrina servisse da forte paravento contro la possibilità di scivolare o precipitare nell’eterodossia, se non peggio. Molti ritenevano che fosse una convinzione non negoziabile della loro identità teologica evangelica.
Billy Graham e Carl F. H. Henry
Certamente due dei principali evangelici americani del secondo dopoguerra, Billy Graham e Carl F. H. Henry compresero l’importanza della dottrina e il suo valore come indispensabile guardrail. Poco prima della famosa Crociata di Los Angeles del 1949, Graham ebbe dei dubbi sull’autorità e la veridicità della Bibbia. Pare che Chuck Templeton, che era stato uno dei più talentuosi evangelisti della Gioventù per Cristo, avesse dichiarato che Billy non sarebbe mai arrivato chissà quanto lontano, date le sue opinioni conservatrici sulle Scritture. Lo si sentì dire: “Povero Billy, mi dispiace per lui. Io e lui stiamo prendendo due strade diverse”*. E in effetti è stato così. Templeton finì per diventare agnostico e, poco prima di morire, disse con le lacrime agli occhi: “Mi manca Gesù”.
Graham fu seriamente colpito dalle critiche di Templeton alla Bibbia. Nel primo fascicolo di Christianity Today (1956), Graham scrisse un articolo straordinario intitolato “Biblical Authority in Evangelism”, un pezzo che vale la pena leggere ancora oggi. Nell’articolo (e nella sua autobiografia, Così come sono) descrisse come una sera, turbato dai suoi dubbi sull’autorità delle Scritture, si fosse recato nei boschi vicino al campo di Forest Home, sulle montagne intorno a Los Angeles. Graham pose la sua Bibbia aperta su un ceppo e pregò.
Delle esatte espressioni usate in preghiera si è persa la memoria, ma devono aver fatto eco ai miei pensieri: “O Dio! Ci sono molte cose che non capisco in questo libro. […] Non so rispondere ad alcune delle domande filosofiche e psicologiche che Chuck e altri pongono”..
Stavo cercando di essere franco e onesto con Dio, ma qualcosa rimase non detta. Infine lo Spirito Santo mi liberò per dirla: “Padre, intendo accettare questa come tua Parola, per fede!
[…]
Avvertii la presenza e la potenza di Dio come non le avevo sentite da mesi. Non a tutte le mie domande trovai una risposta, ma era stato attraversato un ponte principale. Nel cuore e nella mente, sapevo che una battaglia spirituale era stata combattuta e vinta nella mia anima.
Graham ha poi riportato che questo rinnovato impegno nei confronti dell’autorità delle Scritture costituì il “segreto” del suo ministero. Egli ci ricorda che la Sacra Parola di Dio ha un grande potere di trasformare la vita delle persone. A volte possiamo studiare le Scritture in modo accademico e, paradossalmente, perdere il senso del loro potere come Parola di Dio.
Graham raccontò cosa avesse sperimentato dopo aver iniziato a dipendere dalla potenza della Parola autorevole di Dio nella predicazione:
Le persone non venivano per ascoltare una grande oratoria, né erano interessate solo alle mie idee. Ho scoperto che erano disperatamente affamati di ascoltare ciò che Dio aveva da dire attraverso la Sua Santa Parola. Mi sentivo come se avessi una spada in mano e, attraverso il potere della Bibbia, stessi colpendo profondamente le coscienze degli uomini, portandoli ad arrendersi a Dio. La Bibbia non dice forse di se stessa: “’Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l’anima dallo spirito, le giunture dalle midolla; essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4:12)? Ho scoperto che la Bibbia era diventata una fiamma nelle mie mani. Quella fiamma scioglieva l’incredulità nel cuore delle persone e le spingeva a prendere una decisione per Cristo. La Parola era diventata un martello che spezzava i cuori di pietra e li modellava a somiglianza di Dio. Non ha forse Egli detto: “’farò in modo che la parola mia sia come fuoco nella tua bocca” (Ger. 5:14) e “La mia parola non è forse come un fuoco […] e come un martello che spezza il sasso?” (Ger 23: 29)*
Per Billy Graham l’autorità biblica e l’evangelizzazione sono diventate un connubio meraviglioso. Avrete notato che nei suoi messaggi il dottor Graham dichiarava ripetutamente: “La Bibbia dice”. Negli ultimi 60 anni, milioni di persone in tutto il mondo hanno risposto al messaggio evangelico di Graham e hanno accettato Gesù Cristo come Signore e Salvatore.
Infine Carl F. H. Henry, uno dei principali protagonisti della rinascita evangelica dopo la seconda guerra mondiale, ha scritto un elegante articolo nel 1991 in cui anch’egli incoraggiava i cristiani evangelici a tenere in grande considerazione l’autorità biblica. Henry ci ricorda che non serviamo nessun Cristo se non il Cristo secondo le Sacre Scritture.
In modo commovente, Henry ci aiuta a comprendere meglio la natura della nostra identità evangelica in relazione al Vangelo, all’autorità della Sacra Scrittura e a Cristo. Henry ha intitolato il suo pezzo di chiusura “If I Had to Do It Again” (traduzione letterale “Se tornassi indietro”, edizione italiana non disponibile, N.d.T.). Ha scritto:
Fin dall’inizio del mio cammino cristiano ho fatto tesoro del Libro che parla del Dio degli inizi e della fine ultima, e che illumina tutto ciò che sta nel mezzo. […] Un cristiano evangelico crede a una notizia incomparabilmente buona: Cristo è morto al posto dei peccatori ed è risorto il terzo giorno come capo vivente della Chiesa dei nati di nuovo, del popolo di Dio, la cui missione è ordinata dalla Parola scritta di Dio. Il termine evangelico, la cui radice deriva direttamente dal termine “evangelo”, abbraccia quindi la migliore di tutte le buone novelle, vale a dire quella che Dio, grazie alla morte sostitutiva di Cristo Gesù, perdona i peccatori penitenti e mette al riparo il loro destino eterno grazie al Signore risorto che ha trionfato sulla morte e su tutto ciò che avrebbe distrutto Lui e la Sua causa. Questa buona notizia, come chiarisce l’apostolo Paolo, è convalidata e verificata dalle sacre Scritture. Chi contrappone l’autorità di Cristo all’autorità delle Scritture lo fa ad alto rischio. Le Scritture ci forniscono l’autentico insegnamento di Gesù, e Gesù ha esortato i suoi apostoli ad avvicinarsi alle Scritture come divinamente autorevoli. Non esiste alcun florido cammino per il futuro di alcuna causa teologica che fornisca un’autorità scritturale frammentata e, di conseguenza, una cristologia instabile. Fondata dal Signore vero e vivente e armata della veridicità delle Scritture, la Chiesa di Dio è invincibile. Qualunque cosa io voglia cambiare in questa vita da pellegrino, di certo non sarà nessuno di questi nobili e santi obblighi.*
Il dottor Henry aveva scritto queste righe conclusive riguardanti l’identità evangelica solo pochi anni prima che lo incontrassi mentre camminava sul marciapiede della Trinity Evangelical Divinity School, all’inizio degli anni Novanta. Dopo la nostra breve conversazione, Henry continuò a camminare verso il suo prossimo appuntamento. Avrei voluto parlargli delle evidenti debolezze della nuova storiografia, che dipingeva l’inerranza biblica come se fosse un’innovazione dottrinale fondamentalista invece che una dottrina della Chiesa evangelica. Ma non l’ho fatto.
Spero che, mentre si recava al suo appuntamento, sia stato confortato dal ricordo della sua stessa descrizione dell’identità evangelica e dei suoi obblighi “nobili e santi” nei confronti di Cristo e delle Sacre Scritture. Dopotutto essi avevano un fondamento biblico e risiedevano perfettamente negli insegnamenti centrali delle Chiese occidentali dall’epoca patristica alla Riforma protestante, fino alla fine del XX secolo. E rimangono alcuni degli elementi teologici salienti che costituiscono una coerente identità evangelica agli inizi del XXI secolo.
*Traduzione non ufficiale. Edizione italiana non disponibile o non reperibile, N.d.T.
Articolo apparso originariamente in lingua inglese su The Gospel Coalition.