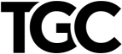Di recente ho tenuto due sermoni di attualità sulla coscienza: “La coscienza e il cristiano” e “La coscienza e la chiesa locale”. Per accompagnare i sermoni, ho sviluppato due grafici che affrontano i diversi aspetti di come dovremmo gestire le nostre coscienze e di come dovremmo relazionarci con le coscienze degli altri.
Ecco il primo, che io chiamo “Lo spettro della coscienza”.

Come funziona la coscienza
La coscienza è il nostro senso interiore di giusto e sbagliato, e giudica tutto ciò che si è fatto o che si sta pensando di fare.
A rigor di termini, la coscienza emette solo giudizi in bianco e nero (si veda ad esempio Rom 2:15, “accusano” o “scusano”). Sia che si guardi indietro a qualcosa che si è fatto o avanti a qualcosa che si sta considerando di fare, la coscienza dice solo “giusto” o “sbagliato”. Partendo dall’estremità sinistra dello spettro, la coscienza dice solo se un’azione sia proibita o meno. Tutti i comandamenti negativi della Scrittura (“Non […]”) proibiscono categoricamente determinate azioni. Andando verso l’estremità destra, la coscienza dice se un’azione sia richiesta o meno. Tutti i comandamenti positivi della Scrittura richiedono determinate azioni, sebbene alcune di queste dipendano da condizioni preesistenti (“Mariti, amate le vostre mogli”, ad esempio, dipende ovviamente dall’essere sposati).
La coscienza è il nostro senso interiore di giusto e sbagliato, e giudica tutto ciò che si è fatto o che si sta pensando di fare.
Il motivo per cui ho riempito entrambe le estremità dello spettro con il nero è che in entrambi i casi la coscienza è vincolata. Se la coscienza dice che qualcosa è proibito o richiesto, il comportamento che ne consegue viene da essa vincolato. Viene dato un ordine che deve essere ascoltato. Qualunque cosa sia proibita dalla Parola di Dio, dovrebbe essere proibita dalla nostra coscienza, e qualunque cosa sia da Essa comandata, dovrebbe essere comandata dalla nostra coscienza. Ma, a causa del peccato, nessuno ha la coscienza perfettamente allineata alla volontà di Dio. Tuttavia la volontà di Dio è lo standard in base al quale dovremmo ricalibrare continuamente le nostre coscienze.
Detto questo, le coscienze dei cristiani saranno di volta in volta vincolate e svincolate a seconda di ciò che comprendiamo essere richiesto dalla Scrittura e di come comprendiamo gli scenari del mondo reale. Il fatto che le coscienze dei cristiani che credono nella Bibbia differiscano su alcune questioni teologiche e pratiche, come chi dovrebbe essere battezzato o in che modo votare, non significa che tali questioni siano irrilevanti. Dirò di più sul disaccordo teologico in seguito.
Ogni qualvolta la coscienza non sia vincolata né da un obbligo né da un divieto, ci si trova liberi di agire (o di non agire). Si tratta qui di questioni in cui la Scrittura non vincola la coscienza né in un modo né nell’altro: determinate azioni non sono né proibite né richieste. Quando una questione rientra nella zona chiara centrale, si potrebbe chiedere consiglio sul modo di agire, ma nessun amico cristiano, leader di chiesa o standard cristiano dovrebbe dare ordini sul da farsi. Sarebbe un andare oltre la volontà di Dio e vincolare la coscienza laddove Egli non l’ha fatto.
Si noti però che ho ombreggiato i bordi dello spazio libero con delle linee oblique. Questo perché i confini a volte non sono chiaramente definiti. Non si è sempre sicuri di cosa la coscienza stia dicendo, o se sia effettivamente la coscienza ciò che ci opprime. Ci sono azioni che la Parola di Dio non proibisce severamente, ma sicuramente sembrano essere cattive. Un saggio amico o un pastore potrebbero metterti in guardia o consigliarti di non fare una determinata cosa, ma tale consiglio non dovrebbe essere preso come un ordine divino. E viceversa ci sono azioni che la Parola di Dio non richiede strettamente che vengano fatte, ma che sembrano sufficientemente sagge, redditizie e benefiche sia per te che per gli altri che qualcuno potrebbe incoraggiarti fortemente a compierle.
In questo territorio siamo ancora nel regno del consiglio, non dell’ordine. Mantenere una chiara distinzione tra i due protegge la propria coscienza, protegge la libertà cristiana e, in ultima analisi, protegge il vangelo.
Come gestire le diverse coscienze
Cosa succede quando i cristiani non sono d’accordo su ciò che appartiene alle sezioni nere, bianche o ombreggiate? Cosa succede se qualcuno pensa che una determinata azione sia un peccato, ma un altro membro di chiesa sembra non essere dello stesso avviso? Ed ecco dove entra in gioco il secondo grafico, un diagramma di flusso che possiamo chiamare “Come non giudicare”.

Prendendo spunto da Romani 14:1–15:7, l’obiettivo in questo diagramma di flusso è quello di capire come reagire quando il peccato di un altro credente ci disturba riuscendo però a non giudicare la persona, azione contro cui Paolo mette ripetutamente in guardia (Rom 14:3-5, 10, 13). Supponiamo che questa persona sia un membro della chiesa locale. Lo vediamo fare qualcosa o lo sentiamo dire qualcosa che pensiamo sia un peccato. Cosa si dovrebbe fare?
Perdonare
Iniziamo chiedendoci: “questo peccato è contro di me?” Se lo è, il nostro primo ordine del giorno è quello di perdonare la persona. Il perdono è interiore e verticale prima ancora che esteriore e orizzontale.
Ogni volta che qualcuno pecca contro di noi, siamo obbligati, entro i confini del nostro cuore, a rifiutarci di far pagare il peccato a quella persona, a rifiutarci di punirla per questo e a desiderare il suo bene con amore. Questo è ciò che Gesù insegna in Marco 11:25: “Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate; affinché il Padre vostro, che è nei cieli, vi perdoni le vostre colpe” (il libro Forgive di Tim Keller è eccezionale su questo punto).
Se il peccato è relativamente minore, dopo aver perdonato la persona è spesso meglio semplicemente tollerare. In altre parole: perdona e vai avanti. Non c’è bisogno di dire niente.
Se il peccato è relativamente minore, dopo aver perdonato la persona è spesso meglio semplicemente tollerare.
Come ci esorta Paolo: “Vestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi” (Col 3:12-13).
Riconciliarsi (quando possibile)
Ma il perdono potrebbe non essere l’unica cosa da fare. Quand’è che si dovrebbe dire qualcosa alla persona che ha peccato contro di noi? La risposta più semplice è “Quando il suo peccato continua a disturbarci”. Potrebbe disturbarci a causa di quanto seriamente siamo stati danneggiati. Oppure, anche se non si è stati personalmente coinvolti, potrebbe esserci della preoccupazione per ciò che questo peccato dice sullo stato spirituale di quella persona.
In ogni caso, se il suo peccato è sufficientemente grave da continuare a lampeggiare sul nostro radar morale ed emotivo, probabilmente è meglio parlargliene. Questo è ciò che Gesù insegna in Matteo 18:15–17 e Luca 17:3–5. Si tratta di uno sforzo per estendere il perdono verso l’esterno e orizzontalmente.
L’essere in grado di estendere con successo quel tipo di perdono dipende prima di tutto dall’aver già perdonato quella persona nel nostro cuore. Dipende anche dal suo pentirsi del suo peccato e dalla sua richiesta di perdono. È possibile controllare solo la prima parte. Ecco perché Paolo dice: “Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini” (Rom 12:18).
Certo, in un certo senso si può estendere il perdono ad una persona indipendentemente dal fatto che lei lo chieda. Ma affinché la relazione sia riconciliata e ripristinata, affinché il perdono sia offerto e ricevuto, quella persona deve pentirsi.
Pregare e decidere se dire qualcosa
E se il peccato non fosse contro di noi? Quello che non bisogna fare è giudicare, condannare, amareggiarsi o nutrire risentimento. Come dice il detto popolare, “il risentimento è come bere del veleno e aspettare che l’altra persona muoia”. Iniziamo invece pregando per la persona e non dicendo niente a nessuno tranne che a Dio.
Ma quando si dovrebbe dire qualcosa? Dopotutto, come dice Keller, “non è mai amorevole permettere a qualcuno di continuare a peccare in modo grave”. Come dice Paolo (parlando non del peccato contro di noi, ma del peccato in cui qualcuno è stato “colto” o “sorpreso”): “Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi, che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine” (Gal 6:1).
Ecco due domande chiave da porsi: (1) Quanto si è sicuri che si tratti di peccato? e (2) Quanto è grave quel peccato? Più alto è il punteggio del peccato su entrambi i conteggi, più è probabile che si debba dire qualcosa.
E se si prova a parlare con l’altra persona e si scopre di non essere d’accordo sul fatto che l’atto in questione sia un peccato?
Un fattore da considerare è se alla radice ci sia una differenza teologica. Un cristiano può vedere la domenica come lo Shabbat, e pensare che sia un peccato svolgere qualsiasi tipo di lavoro, un altro no. Volendo, si può affrontare la questione teologica. Ma, come ricorda Romani 14, è bene riconoscere che ci sono questioni teologiche e pratiche su cui i cristiani continueranno a non essere d’accordo. Siamo in disaccordo sullo Shabbat da 2000 anni. Questo potrebbe essere un caso con cui si deve convivere!
È importante riconoscere che l’intera discussione di Paolo in Romani 14:1–15:7 è costruita sulla convinzione che i cristiani dovrebbero essere in grado di vivere insieme in ricca armonia, come membri della stessa chiesa, nonostante i continui scontri di coscienza.
I cristiani dovrebbero essere in grado di vivere insieme in ricca armonia, come membri della stessa chiesa, nonostante i continui scontri di coscienza.
Se non c’è una differenza teologica in gioco, è bene assicurarsi di essere d’accordo sulla morale in base alla quale viene valutato il problema. La coscienza funziona applicando una regola ad una situazione specifica. Valuta il particolare alla luce dell’universale. Un giudizio di coscienza comporta la valutazione di una situazione al di fuori della Bibbia facendo riferimento ad un principio della Bibbia. Ci sono sempre due parti coinvolte nel giudizio.
Quindi, se si decide di proseguire la conversazione con il fratello o la sorella con cui sì è in disaccordo, è bene cercare ogni passaggio e principio scritturale rilevante. Bisogna metterli tutti sul tavolo e guardarli insieme. Bisogna assicurarsi di essere d’accordo sulla base biblica riguardo al modo di valutare il comportamento in oggetto. Solo allora sarà possibile discutere l’azione. Ognuno deve avere la possibilità di descriverla. E se pensiamo che l’altra persona abbia una comprensione incompleta del comportamento discusso, si può provare a offrirle dei miglioramenti e vedere se la si trova d’accordo.
Preferenza ≠ Convinzione
Anche qui i cristiani non saranno d’accordo. Andare a cinque km/h oltre il limite di velocità è un peccato? E l’attraversare fuori dalle strisce pedonali? O non lasciare la mancia al ristorante? (in Paesi in cui nel conto non è incluso il coperto, dare la mancia è una sorta di “dovere non scritto”. N.d.R.) Si può riconoscere di essere d’accordo sulla regola scritturale e non sulla sua applicazione.
Individuare la fonte del disaccordo aiuta a contenerlo. Il disaccordo si trova solo lì. Non si tratta della signoria di Cristo, ma se questa azione violi quella regola. E ricordiamo che non tutti i disaccordi sono una questione di coscienza. Alcuni sono semplicemente preferenze. Non tutte le preferenze sono una convinzione di coscienza.
Apparso originariamente in lingua inglese su The Gospel Coalition (USA)